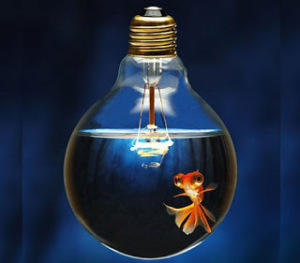A distanza di oramai due mesi, non si placano le polemiche sulla sentenza della Corte Suprema Indiana che ha respinto il ricorso della Novartis circa la tutela del brevetto della versione aggiornata dell’antitumorale Glivec. Una questione, purtroppo relegata solo sulla carta stampata, non ancora discussa dagli esponenti della Bioetica italiana che continuano a tenersi alla larga dalla vicenda. Ma riassumiamo brevemente i fatti.
Lo scorso aprile, la Corte Suprema Indiana ha respinto il ricorso di Novartis riguardante la tutela del brevetto della versione aggiornata di Glivec, un antitumorale utilizzato per il trattamento della leucemia mieloide e delle altre forme tumorali.
Il farmaco costa quasi 2.600 dollari al mese, mentre il suo equivalente è disponibile per soli 175 dollari.
Per i giudici, il Glivec non sarebbe una “invenzione”, ma solo la riformulazione dell’Imatinib, una molecola il cui brevetto è scaduto. La sentenza si lega alla legge indiana sui brevetti, modificata nel 2005, secondo la quale “le nuove versioni di un farmaco possono essere brevettate solo qualora sia dimostrata la loro maggiore efficacia terapeutica rispetto a precedenti versioni, il cui brevetto sia scaduto”. La decisione delle autorità indiane di contrastare le grandi aziende farmaceutiche corona una normativa promulgata contro tutta una serie di scorciatoie messe in atto dalle multinazionali farmaceutiche per prolungare la scadenza di alcuni brevetti con migliorie formali, ma non sostanziali e, pertanto, sistematicamente rigettate dall’India. (in tal senso sono stati sconfitti diversi farmaci prodotti dai colossi Pfizer e Roche, compreso l’antitumorale Tarceva).
La sentenza è stata salutata positivamente da numerose organizzazioni umanitarie, prima tra tutti Medici senza Frontiere. Ma, come dicevamo prima, assordante è il silenzio su questa vicenda da parte degli esponenti del mondo della Bioetica italiana dove quasi nessuno ha fatto notare – lo sottolineava Marcia Angell, ex direttrice del New England Journal of Medicine – come tutta la ricerca di base sull’Imatinib mesilato – commercializzato con il nome Glivec dalla Novartis, quando erano già stati ottenuti dati molto promettenti sulla sua efficacia clinica e che ha fruttato all’azienda, solo nel 2012, un fatturato di 4,6 miliardi di dollari -, è stata effettuata in istituzioni accademiche grazie a finanziamenti prevalentemente pubblici.
Il caso del Glivec è emblematico rispetto ad una privatizzazione della ricerca scientifica che sta comportando una crescente emarginazione, esclusione dei poveri, dai progressi della Medicina. Una crescente emarginazione che rischia di trasformarsi in esclusione, se si considera quanto sta accadendo circa la nuova normativa sui brevetti di farmaci che viene imposta ai Paesi come condizione per l’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization, WTO).
La cosa avvilente del clamore suscitato dalla questione Glivec è stata la sua raffigurazione, da parte della stragrande maggioranza mass media, come un furbo tentativo delle autorità indiane di difendere l’industria locale di farmaci generici, un settore così in crescita che è valso all’India il nome di “farmacia dei Paesi poveri”. Ma anche se il reale movente fosse questo, la decisione della Corte Suprema indiana potrebbe realmente fare la differenza per milioni di persone in tutto il mondo. Tale sentenza potrebbe infatti stabilire un importante precedente anche per prossime dispute sulla proprietà intellettuale e rappresentare un deterrente per futuri abusi da parte di Big Pharma (secondo cui la sentenza della Corte Suprema indiana “scoraggia “ogni investimento sui farmaci del futuro” e minaccia rappresaglie).
Ma i brevetti sui farmaci rappresentano realmente un incentivo alla futura innovazione? Se ci si sofferma sul caso del Glivec, sviluppato con fondi prevalentemente pubblici, la risposta è indubbiamente di segno negativo. Ed è negativa anche analizzando i dati forniti da FDA (Food and Drug Administration) relativamente all’approvazione dei nuovi farmaci. Dal 1990 ad oggi l’ente regolatorio statunitense ha autorizzato 1986 nuovi farmaci. Di questi 660 erano nuove entità molecolari e solo 250 hanno goduto della procedura di analisi privilegiata che FDA riserva alle reali innovazioni da un punto di vista terapeutico, con un tasso di innovazione medio pari al 12,6%. Nel corso dei 23 anni considerati, nonostante le tutele offerte dai diritti di proprietà intellettuale e i “celebrati” investimenti nel settore “Ricerca e Sviluppo”, il grado di innovatività si è ridotto progressivamente. Al dato quantitativo aggiungiamo anche un’analisi qualitativa. Tra i farmaci annoverati quali reali innovazioni farmacologiche troviamo Vioxx, Avandia, Tamiflu e altri le cui vicende sono tristemente note e che a distanza di anni potremmo difficilmente considerare dei virtuosi modelli di progresso terapeutico. Inoltre, la possibilità di sfruttare, dal punto di vista economico, i risultati delle proprie ricerche non ha sortito praticamente alcun effetto nell’orientare le priorità di ricerca e di sviluppo verso le patologie prevalenti nei Paesi a risorse limitate che, di fatto, continuano a non rappresentare un mercato appetibile per Big Pharma.
Come si vede, si tratta di questioni di estremo interesse anche in Italia dove la progressiva privatizzazione del Servizio Sanitario e i crescenti tagli a questo porranno tra breve anche da noi la tragedia di farmaci troppo costosi per essere somministrati ai poveri. Sarebbe sembrato ovvio, quindi, un interessamento del mondo della Bioetica italiana. Invece, nulla. Come Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica (1995-98), vengo quotidianamente sommerso – prima da lettere, ora da mail – di innumerevoli inviti a convegni, tavole rotonde, dibattiti…. Ma, nonostante il clamore mediatico, non ne ho trovato neanche uno dedicato al caso Novartis. Perché questo apparente disinteresse da parte di illustri clinici, prestigiosi ricercatori, insigni accademici ad occuparsi del caso Novartis e, più in generale del potere di Big Pharma?
E come diceva Oscar Wilde: “Val sempre la pena di fare una domanda, soprattutto se si già il perché della mancata giusta risposta”
Prof. Giulio Tarro