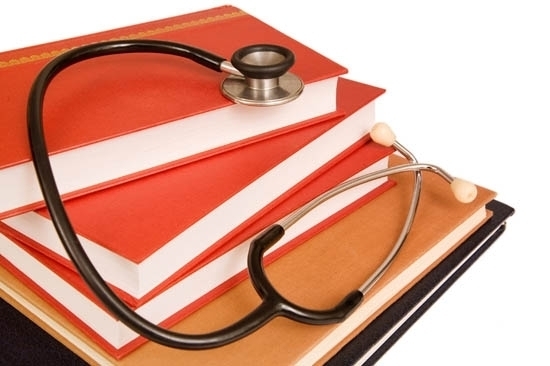
Da alcuni anni, in Italia e non solo, da quando cioè si è cominciato a valutare con maggiore attenzione il “peso” della produzione scientifica, si fa sempre più riferimento all’ Impact Factor (IF) di una rivista scientifica, forse attribuendogli un’importanza eccessiva. Ecco, quindi, alcune riflessioni o meglio le risposte alle più frequenti domande sull’IF Che cos è ? — L’invenzione dell’ IF si deve a Eugene Garfield nel 1963, che originariamente pensò di sviluppare uno strumento in grado di aiutare nella catalogazione delle collezioni di riviste e giornali, a tutto vantaggio di biblioteche e ricercatori. Esso si basa essenzialmente sulle statistiche di citazione, e misura la frequenza con la quale un “articolo medio” viene citato da altre riviste in un determinato periodo (generalmente un anno). Attualmente l’ IF è di proprietà dell’ISI (Institute for Scientific Information). Come si calcola ? — L’ IF non è altro che il rapporto tra il numero totale di citazioni e gli articoli pubblicati da una determinata rivista, riferito ad un anno specifico. Ad esempio, l’ IF di una rivista per l’anno 2006 è rappresentato dal risultato di una frazione il cui numeratore è il costituito dal numero di citazioni ricevute da quella rivista nei due anni precedenti (nel nostro caso, 2004 e 2005), ed il denominatore dal numero di articoli “citabili” pubblicati dalla stessa rivista nel medesimo periodo. A cosa serve ? — Secondo le intenzioni originarie, l’uso primario era rappresentato dalla gestione e catalogazione delle collezioni di riviste e giornali. Secondariamente, e grazie anche a criteri aggiuntivi, è stato utilizzato come strumento per paragonare dati da parte di: editori; responsabili di riviste; inserzionisti pubblicitari; commissioni accademiche. Tuttavia, esso viene utilizzato spesso impropriamente. Secondo Garfield “l’ISI non utilizza l’ IF da solo nella valutazione dell’utilità di una rivista, e nessuno dovrebbe farlo” … “esistono molti artefatti in grado di alterare l’ IF di una rivista e conseguentemente la sua posizione nell’elenco delle riviste, non ultime le inclusioni di articoli di revisioni oppure lettere”. E vediamo adesso alcuni altri usi (o abusi) dell’ IF non propriamente contemplati dall’ISI: 1) Capi dipartimento che obbligano a inviare lavori scientifici quasi esclusivamente a riviste con un elevato IF; 2) Istituzioni europee che usano l’ IF per stabilire l’assegnazione di fondi; 3) Ricercatori che indicano l’ IF della rivista sul proprio CV; 4) Commissioni giudicanti (accademiche o intraziendali) che valutano i candidati utilizzando l’ IF per valutare la qualità della loro produzione scientifica; 5) Board di Società Scientifiche che giudicano lo stato di salute delle loro riviste ufficiali e l’operato degli Editors-in-Chief a seconda dell’ IF e del relativo posizionamento nella classifica di categoria. Inoltre, non vanno sottovalutate alcune controversie legate all’ IF: 1) Esso, da solo, non indica la qualità né del contenuto scientifico né della “peer review”; 2) L’ IF, come detto prima, rappresenta un stima media e, pertanto, può indurre ad errori di valutazione. Infatti, un piccolo sottogruppo può da solo contribuire alla maggioranze delle citazioni; 3) Il denominatore (ovvero il numero totale degli articoli pubblicati) non include alcuni tipi di articoli “non citabili” (ad esempio, lettere, recensioni di libri, abtracts), ma ciò che viene o non viene citato differisce da rivista a rivista; 4) Il numeratore include citazioni di questo materiale “non citabile”, il che potrebbe certamente “gonfiare” l’ IF di alcune riviste; 5) Gli articoli di ricerca di base risultano avvantaggiati dal fatto che si citano tra loro, a differenza degli articoli ad interesse clinico che citano entrambi; 6) L’ ISI è una società commerciale e come tale trae profitto economico dal numero di accessi al suo database. Pertanto, se da una parte sottolinea come l’ IF sia utilizzato con modalità diverse da quelle per le quali fu ideato, dall’altra il costante interesse che esso suscita si traduce in un evidente vantaggio economico; 7) Il periodo di riferimento di due anni risulta arbitrario. Molti articoli, infatti, continuano ad essere citati anche dopo tale periodo, senza più alcun “impatto” sull’ IF. Volendo trarre alcune conclusioni, si può affermare che i principali problemi legati all’ IF siano: L’ IF è uno straordinario strumento di valutazione dei dati della letteratura ma che parimenti rappresenta una misura controversa. Sebbene ideato per altri scopi, l’ IF viene attualmente utilizzato come indicatore indipendente della qualità e dell’utilità di una rivista scientifica.Nonostante vi sia la piena consapevolezza di questi usi “non ortodossi”, l’ IF continua ad essere utilizzato in tale modo, ed è verosimile che lo sarà anche nel futuro.
Francesco de Blasio
MD, FCCP Unità Funzionale di Pneumologia e Riabilitazione RespiratoriaCasa di Cura Clinic Center S.p.A








