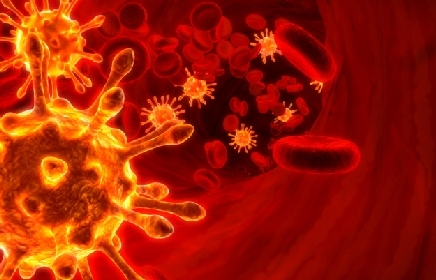Vi sono due studi, in corso di pubblicazione, sul virus influenzale H5N1 che è stato creato in laboratorio da un gruppo di ricercatori facenti capo a Ron Fouchier, del centro medico Erasmo di Rotterdam, Olanda, e da un altro gruppo capeggiato da Yoshihiro Kawaoka dell’Università Wisconsin, Madison, e dell’ università di Tokio.
Gli studi di tale virus, geneticamente modificato, e trasmesso tra i furetti, che mimano l’influenza umana affermano che se il virus fosse liberato o emerso in natura potrebbe, potenzialmente, dare origine ad una pandemia influenzale con milioni di morti.
Secondo i ricercatori la conoscenza della eziopatogenesi da H5N1 sarebbe utile perché potrebbe fornire elementi preventivi per intervenire con delle contromisure specifiche.
Altri studiosi criticano il fatto che i virus prodotti in laboratorio potrebbero liberarsi nell’ ambiente oppure, dopo la pubblicazione dei dati, fornire al bioterrorismo la ricetta della loro sintesi.
Il genetista microbiologo Paul Keim che presiede il comitato nazionale di biosicurezza degli Stati Uniti, pensa che non vi sia un altro microrganismo patogeno che possa spaventare come questo. Perfino l’antrace non è comparabile a questo virus influenzale aviario H5N1 che è trasmissibile ai mammiferi.
Sin dal 1997, data della sua comparsa in Asia, il virus ha decimato i polli in tre continenti, ma ha causato meno di seicento casi di influenza umana, sebbene spesso mortali.
Dal momento che si propaga in maniera poco efficiente nella specie umana, non è stato in grado di provocare una pandemia mondiale. L’H5N1 ha difficoltà ad adattarsi all’ospite uomo e, quindi, a riprodursi, necessitando, forse di un riassortimento con un ceppo umano: questo processo di organizzazione dei geni sembra potersi attuare nei maiali che ospitano sia ceppi aviari che umani.
Nella sua prima comunicazione in un convegno a Malta nel settembre scorso, Fouchier ha sostenuto di avere avuto difficoltà a modificare geneticamente il virus per renderlo più trasmissibile e, quindi, ha ripetutamente trasmesso il virus da un furetto all’altro. Dopo dieci generazioni, il virus è diventato capace di trasmettersi per via aerea ed infatti si sono ammalati animali sani soltanto per il fatto di trovarsi col furetto influenzato nella stessa gabbia. Tale ceppo presentava cinque mutazioni in due geni, ognuna delle quali già presente in natura, ma giammai insieme nello stesso ceppo. Dal momento che qualsiasi ceppo influenzale, che è stato trasmesso da un furetto ad un altro, è diventato pure trasmissibile per l’uomo, e viceversa, lo stesso meccanismo può accadere per la specie umana.
Michael Osterholm, direttore del centro di ricerche per le malattie infettive dell’Università del Minnesota, Twin Cities, pensa che alcuni dettagli del lavoro potrebbero essere omessi dalla pubblicazione e resi noti solo agli esperti dell’ influenza. La creazione di un virus pandemico è l’ esempio classico di ricerca a doppio uso, che potrebbe fornire benefici alla salute pubblica, ma anche risultare nefanda, e di cui si discute ancora nel 2011 dopo la grande attenzione e precauzione prestata nell’ultima decade. Non bisogna attendere la fine dell’esperimento e concludere che è pericoloso prima di sottoporre i risultati per la pubblicazione.
I ricercatori e le istituzioni come gli enti finanziatori dovrebbero conoscere questo pericolo prima della pubblicazione, che è l’ultimo atto. Adesso non resta che sfruttare gli aspetti positivi della ricerca, non abbassando la guardia nel caso di una potenziale epidemia da virus H5N1 e, conoscendo le esatte mutazioni che permettono la trasmissibilità del virus, intervenire, quindi, con drastiche misure preventive. Infine, si può già saggiare se i vaccini per il virus H5N1 ed i farmaci antivirali siano in grado di funzionare contro il nuovo ceppo potenzialmente letale.
Il genoma, cioè il complesso dei geni, del virus influenzale è costituito da 8 segmenti di RNA che codificano per 10-11 polipeptidi differenti. La superficie delle particelle virali è in gran parte costituita da 2 glicoproteine, l’ emoagglutinina (HA) e la neuroaminidasi (NA), ed un piccolo numero di proteine M2, che servono per la rimozione del capside del virus e la sua maturazione. La proteina HA, che rappresenta il prevalente antigene di superficie, è responsabile per il legame delle particelle virali all’ acido sialico della superficie cellulare e per la successiva fusione della parte esterna virale con la membrana cellulare liberando il genoma virale nelle cellule bersaglio. Le funzioni della proteina NA servono per liberare il virus che germoglia dalle cellule infette mediante la separazione dalle molecole di acido sialico della cellula. In aggiunta, il genoma del virus dell’ influenza A permette lo scambio di segmenti dell’ RNA virale tra virus influenzali geneticamente diversi con il risultato di un nuovo sottotipo virale e/o un nuovo ceppo influenzale.
I tre meccanismi che permetto a questi virus di andare incontro ad un cambiamento evoluzionario sono la mutazione che porta ad un movimento di corrente antigenica, il riassortimento, cioè riorganizzazione dei geni che porta alla sterzata antigenica, ed anche, sebbene raramente, la ricombinazione.
Con il primo processo, le mutazioni sono incapaci di essere riparate, e l’accumulo conseguente di mutazioni multiple ha un impatto significativo sull’ efficacia del vaccino stagionale. Per questa ragione, l’evoluzione annuale della formula vaccinale è necessaria per assicurare che il vaccino sia efficace contro le forme attuali dei ceppi virali circolanti.
Mentre l’introduzione di nuove varianti virali nella popolazione umana da altre specie, attraverso il riassortimento tra segmenti genici di un virus influenzale presente nell’uomo e quelli trovati in un altro ospite animale, determinano la sterzata immunologica col risultato della presenza di un nuovo agente patogeno potenzialmente pericoloso derivante dai ceppi originari che potrebbero travalicare le barriere di specie e trovare una popolazione che è immunologicamente indifesa verso questi nuovi ceppi.
Infine, la ricombinazione di virus dell’ influenza A può venire attraverso due principali meccanismi: ricombinazione non omologa che avviene tra due differenti segmenti di RNA e la ricombinazione omologa, più controversia, che si pensa possa implicare lo scambio di modello mentre la polimerasi copia l’ RNA. La comparsa di un nuovo ceppo influenzale può perciò essere riguardata come un processo di sviluppo che implica sia le caratteristiche del virus che la suscettibilità della popolazione. Perché un ceppo virale raggiunga un’ampia distribuzione, le caratteristiche antigeniche debbono assicurare che eviti la neutralizzazione degli anticorpi dell’ ospite e della popolazione circostante. Così l’insorgenza influenzale accadrà con quei ceppi che hanno antigeni dominanti che riempiono il deficit o meglio l’assenza di anticorpi della popolazione. In conclusione, sembra che il virus influenzale mostri l’abilità e l attitudine per sopravvivere dovute all’ emergenza di nuovi ceppi che infettano la popolazione, ancora in parte immune alle precedenti forme antigeniche (processo evoluzionario definito da Burnet sterzata immunologica dell’ influenza A).
Prof. Giulio Tarro